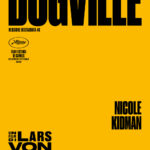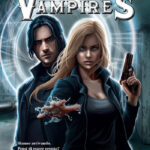Girato durante i sette anni di lavorazione de “Il ragazzo e l’airone”, il documentario è un viaggio esclusivo nel processo produttivo e creativo dello Studio Ghibli e un’immersione nella storica collaborazione di Miyazaki con il produttore Toshio Suzuki.
Miyazaki dichiara da sempre che la sua necessità più grande è far uscire le idee dalla sua testa perché “quando chiude gli occhi, non smette di pensare”. Lo fa perché non riesce a evitare di pensare a un lutto di un caro amico/nemico come Isao Takahata da lui soprannominato Paku-San ma anche perché continua ad avere delle immagini di cui non riesce a liberarsene. Lungo il documentario ci sono pochi riferimenti davvero tecnici sul suo lavoro, su come creare un disegno oppure una sceneggiatura. Piuttosto staremo in compagnia del regista nella sua quotidianità fatta anche di visite ai bambini di una scuola vicino casa sua e di tante sigarette fumate in solitaria.
“Mi sembra di avere la testa rotta” è una dichiarazione di Miyazaki che sentiremo spesso perché non riesce a scappare dalla necessità di disegnare in continuazione chi gli sta attorno facendo spesso analisi di se stesso, del mondo che lo circonda domandandosi perché è solo e le persone a lui più care stanno morendo una dietro l’altra.
Nonostante più volte abbia dichiarato di volersi fermare, non ci riesce perché qualcuno gli dice di continuare ma soprattutto perché è suo bisogno primario e necessità continuare a creare. Passeremo quindi tanto tempo con il regista tra le sue passeggiate continue, i momenti di stallo in cui non riesce a lavorare e della preparazione del bollitore per prepararsi il tè a casa.
Con un countdown che parte da 3598 giorni dal giorno dell’uscita del film al cinema, vedremo la telecamera del regista Awakawa seguire Miyazaki con fare a volte discreto mentre altre volte sembra rubargli momenti più intimi cercando poche volte di interagire direttamente con il regista. Il passo è quello di un documentario che non vuole mai essere d’intrattenimento o costruito e con pochi espedienti d’impatto come divagazioni o virtuosismi banali. Spesso vedremo inquadrature prese dal film stesso ma non vengono messe nel mezzo per spiegare la loro creazione piuttosto per esplicitare un loro collegamento emotivo da parte del regista.
Andrea Arcuri